
Renée Vivien, pseudonimo di Pauline Mary Tarn (Londra, 1877 – Parigi, 1909) è la poetessa che nasce nel ventre della Belle Époque e cresce nell’appellativo di Saffo ‘900. Donna di grande fascino e verseggiatrice di elegante fattura, indossa, non senza un mal celato tribolo, le vaiate vesti di una creatura libera soprattutto nella manifestazione dell’amore per le donne. Dentro un corpo fiaccato dall’anoressia e dall’abuso di alcol, muore a soli trentadue anni a causa di una pleurite che accelera il suo lento declivio verso la morte. Incorniciata da una lunga chioma di capelli biondi e ammantata da un incanto non comune, la poetessa è particolarmente sensibile al canto della morte, una sorta di richiamo che si fa desiderio e infine aspetto legato intimamente all’amore. Innamorata di Baudelaire e Saffo – di quest’ultima la Vivien pubblicherà adattamenti e traduzioni, favorendo il recupero e la valorizzazione della poetessa greca – attraverso endecasillabi, sonetti e poesia in prosa, canta l’amore, sovente tribolato, per la figura femminile. Un carme che la incorona come la prima poetessa francofona a manifestare liberamente l’amore saffico. Nell’opera Il puro e l’impuro, la scrittrice francese Colette le dedicherà diverse pagine:
L’incantevole viso di Renée non rispecchiava che una parte di questa puerilità, nella guancia rotonda e soave, vellutata, nel labbro, superiore ingenuo, rialzato, all’inglese, su quattro denti piccolini. Un sorriso frequente e radioso illuminava i suoi occhi castani, ora bruni, ora verdastri alla luce del sole. Portava lunghi i bei capelli d’un biondo argenteo, fini, lisci, e se li annodava sul sommo del capo in una crocchia che poi si disfaceva, un filo dopo l’altro, come una paglia sottile…
Colette, amica e vicina di casa di Renée, osserva la lenta e volontaria consunzione che affligge la poetessa:
Vuotò il bicchiere d’un colpo, non le mancò il respiro, non battè ciglio, e la sua gota rotonda mantenne il suo floreale candore. Non fu quella sera che mi resi conto che si nutriva di una cucchiaiata di riso, di un frutto, soprattutto di alcool.
Padrona della lingua francese, Renée Vivien lascia numerose poesie in quel luogo edificato sulle fondamenta di un’elegante palazzo di tristezza.
La divinità sconosciuta, una prosa poetica tratta Dal verde al viola:
La donna che amo, la donna sconosciuta, abita in fondo a un antico palazzo dove si ostina una sera perpetua.
Il vecchio palazzo veneziano dove ha germogliato la sua infanzia, dove ha fiorito la sua adolescenza, sonnecchia nel silenzio delle acque morte. L’ombra del passato attenua le fragili sfumature delle stoffe e i colori dei quadri. Si sentono sospirare appena i respiri del mare nelle pieghe delle tende pesanti.
C’è silenzio dentro di lei e intorno a lei.
Si capisce, avvicinandosi, che ha sempre vissuto in solitudine. Ha lunghe mani alle quali la penombra ha dato i toni ingialliti dell’avorio vecchio. Il suo sguardo ha il riflesso delle acque morte. Parla a voce così bassa che bisogna concentrarsi per sentirla. E le sue parole sembrano l’eco di un lamento che nessuno ha mai sentito.
Nella camera dove dimora, si sente la misteriosa presenza dell’Anima. Le piacciono i fiori che appassiscono, e si rattrista voluttuosamente quando il crepuscolo fa cadere con rimpianto i petali di una rosa.
Il suo vestito a lutto ha la dolce consistenza delle tenebre. È come avvolta dalla notte.
I suoi capelli sono intessuti di raggi notturni e mescolati alla porpora, come se l’Ombra avesse svegliato le sue calme violette.
La amo perché mi è sconosciuta ed esiste solo in un sogno.
Renée Vivien era solita portare con sé un mazzolino di violette.









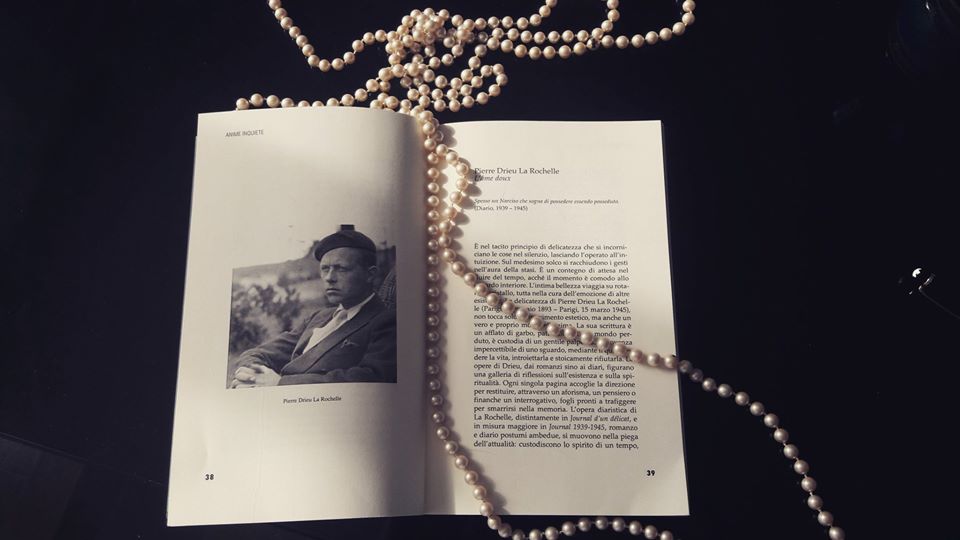
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.