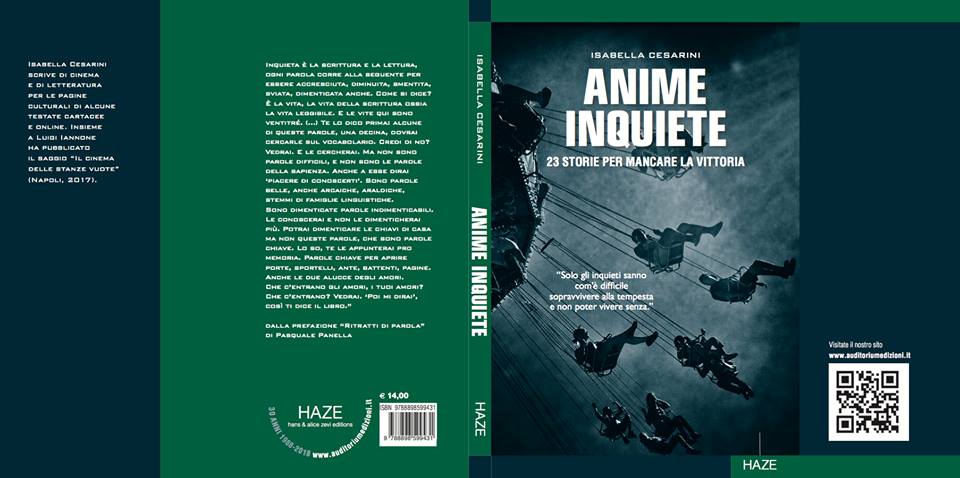
PP
Ritratti di parola
Questo libro di ritratti non è un libro, è la realizzazione di un sogno,
un sogno ingenuo ossia un sogno di tutti, un sogno vero. Questo libro
rende invisibile chi legge, invisibile e capace di volare, così chi legge vola e,
impercettibile, entra nelle finestre, in tutte le finestre — delle stanze, delle
epoche, dei mondi — e vede i corpi. Perché sono corpi, queste anime
inquiete.
Esiste un orario di chiusura dei libri? Forse no. Ma se apri questo
libro hai l’impressione di entrarci dopo l’orario di chiusura. Altro bel
sogno, questo: restare in un deposito di vite senza le ristrettezze del turista
in visita che deve mantenere le distanze. No, qui ti puoi scalmanare, ti puoi
sfrenare, anche eccitare, qui puoi toccar con mano le parole corporali. E
puoi anche entrare nei panni. Chi sono gli altri se non te mascherata, te
mascherato? Ma sì, si sa com’è che va. E qui va benissimo. Qui pare
addirittura che ogni figura appaia ritratta nel tuo specchio, così tu leggi e
guardi e vedi te come se tu fossi Lou Salomé ma anche Jean, Salvador,
Leonor, Maria… Esse e essi vissero. E cosa cerchi in chi visse se non tracce
di te? I bei difetti, le belle scivolate, vite come precipitazioni temporalesche,
vite abbaglianti e abbagliate, vite che, parliamoci chiaro, se fosse stato tuo il
nome di chi le visse, tuo il loro corpo, sarebbero state le tue vite. Eccole
qui, leggibili, sono tue.
Così questo libro è anche una toeletta con tutti i trucchi a vista e con
le alucce laterali per i profili e per le rifrazioni; è un camerino con le luci in
cornice per guardarti meglio. Senti lo scatto illuminante nell’incipit di ogni
ritratto.
Ma sì, sono sportelli, qui, le pagine, sono persiane a due imposte,
porte a due battenti, armadi a due ante con dentro corpi amanti. Si entra e
un po’ si spia, anzi non solo un po’, anche tanto. E chi sono le persone e i
personaggi se non te messo alla prova di quei panni, di quel pallore, di quel
rossore, di quel ghigno, di quelle chiome, di quella calvizie, di quei baffi
(che sono sempre, infatti, posticci, a ben guardare), di quelle belle labbra,
di quei seni, di quei muscoli e nervi? Chi se non te? Se no, che leggi a fare
se non sei chi leggi? Qui è tutto chiaro e illuminato bene. Qui la pagina
trasuda, e trasuda chi legge, ci si scambia la traspirazione e il respiro, qui è
tutto un trasudare di umori e umidità carnali tra chi legge e chi è letto.
Occhio a quel lemma: gemicare, che qui è molto coniugato. Qui è tutto un
trafficare di pose, di mimiche, di movenze, di agitazioni e di frenesie, di
abbandoni e di abbattimenti, di spassi e di passioni, di delusioni e di
elusioni, di veli e di piume, di straccetti e di biancheria, di gesti intermedi e
di gesti estremi. Qui tutto è sala prove, qui tutto è scambio d’abiti che
fanno il monito, tutto è livrea e richiamo, qui tutto è verso, nitrito,
cinguettio, latrato, grugnito, guaito e miagolio dell’animale umano. Qui ti
chiedi se la persona scritta non ti stia osservando, derivando da te la sua
ossessione d’essere chi è. E qui chi visse sopravvive in un ritratto da lettura
ovvero in te che leggi con licenza di razzia, una razzia con gli occhi ma, se
vuoi, anche con le mani e, dalle mani in poi, con tutta la tua pelle che
sfiorerà e si farà sfiorare dagli oggetti del racconto, quegli oggetti
particolari che sono gli episodi, le scene, gli atti, le sorti, le parti delle vite.
Ecco, làsciati chiudere dentro questo libro aperto, conoscerai l’evasione e
l’intrattenimento: la fuga verso un’attrazione a braccia spalancate.
Noi siamo l’umanità, abitiamo un luogo a noi comune, questo
pianetino. Visti da anni luce, visti la lontano, in una mescolanza di storia e
geografia, noi siamo chi non siamo, nel senso che laggiù, per esempio,
arriva la notizia dell’esistenza sulla terra di Sibilla, Lou, Egon, Drieu, Jean,
Gustavo, Salvador, Leonor, Emile, Edith, Clarice, Diane, Sylvia, Françoise,
Agota, Janis, Maria…, e ecco che questi nomi, sfumatura più, sfumatura
meno, sono i nomi con i quali siamo conosciuti noi terrestri, ma sì, quelli
che assieme vissero in un mazzetto di decenni, mescolati e confondibili,
nell’immenso sperpero di miliardi di miliardi d’anni luce.
Guardali così questi ritratti, come notizie delle tue esistenze, perché
chi legge è fatto di parole, delle parole che legge.
Ma essere chi leggi, capita con tutti i libri di ritratti? No, non con
tutti. Spesso si fa pettegolezzo, buttando l’occasione in diceria, oppure si fa
ricerca cavillosa e accumulo di documenti, attestati, certificati, passaporti,
diagnosi, buttando la faccenda in istruttoria abusiva. Si fanno tante cose,
fingendo anche la ricostruzione esatta di una vita, che è una cosa
impossibile e anche assurda. È inesatta la vita. Inesatte anche le foto, lo
sappiamo tutti, e inesatti i ritratti fatti a pennellate.
Qui il ritratto è di parola, mantiene in vita quello che promette.
Come si dice per non dire altro quando fai una nuova conoscenza? Si dice
‘piacere di conoscerti’, che poi raramente è quel piacere. Qui è quel
piacere.
Qui ti senti dire ‘guardami, chiamami per nome, non lo fai mai
guardandomi’. Chi ha parlato? Il ritratto e tu, tutt’uno, con una sola voce.
Pare strano? Per niente. Lo sai benissimo che leggere è mescolanza tra testi,
testi intesi come testimoni. E qui ti puoi permettere confidenze e intimità
che nella vita te le sogni.
Qui che altro si fa? Si fanno visioni. O, anche, si hanno visioni di sé
nel ritratto e del ritratto in sé, con generosa, reciproca licenza di
confondersi. Le figure qui sono volute, nei due sensi, sia nel senso di spinte
a essere dalla voglia di volere essere lette da te che hai voglia di leggerle, sia
nel senso delle evoluzioni del fumo, profumato, irritante, lacrimogeno,
fantasmatico, fosco o bianco, volubile, capriccioso, denso, vago, ma sempre
avvolgente.
Ti orienti in una nebbia, e nella nebbia cerchi una figura, poi scopri
che quella nebbia è la figura. Leggere è anche questo, è quell’essere avvolti
in un vapore formato da te che leggi, da te a contatto con quel suolo di
parole che è la pagina. Qui accade.
Il corso più somigliante al corso di una vita è il corso del rigo di
scrittura, coi suoi punti fermi mai tanto fermi perché poi inizia un’altra
frase, con i suoi a capo per ricominciare, col poco di respiro delle virgole,
con gli accoppiamenti delle congiunzioni, con quel fallito senso di infinito
degli avverbi, con la piaggeria degli aggettivi, con la parola fine. Qui senti
che è così.
Sì, le parole. Qui le parole fanno, oltre che storie, il testo, il ritratto
del testo fatto dalle parole. E allora capisci. Sono loro le anime inquiete, le
parole. E, adesso che lo capisci, è ovvio siccome è vero. Di parole sono fatte
queste storie, queste vite. Le parole, queste parole, sono l’inquieta anima
loro. E tu conosci, sì, l’inquietudine degli occhi di chi legge? Ecco, di
quell’anima là gli occhi sono lo specchio. Inquieta è la scrittura e la lettura,
ogni parola corre alla seguente per essere accresciuta, diminuita, smentita,
sviata, dimenticata anche. Come si dice? È la vita, la vita della scrittura
ossia la vita leggibile. E le vite qui sono ventitré.
Te lo dico prima: alcune di queste parole, una decina, dovrai cercarle
sul vocabolario. Credi di no? Vedrai. E le cercherai. Ma non sono parole
difficili, e non sono le parole della sapienza. Anche a esse dirai ‘piacere di
conoscerti’. Sono parole belle, anche arcaiche, araldiche, stemmi di
famiglie linguistiche. Sono dimenticate parole indimenticabili. Le
conoscerai e non le dimenticherai più. Potrai dimenticare le chiavi di casa
ma non queste parole, che sono parole chiave. Lo so, te le appunterai pro
memoria. Parole chiave per aprire porte, sportelli, ante, battenti, pagine.
Anche le due alucce degli amori. Che c’entrano gli amori, i tuoi amori?
Che c’entrano? Vedrai. ‘Poi mi dirai’, così ti dice il libro








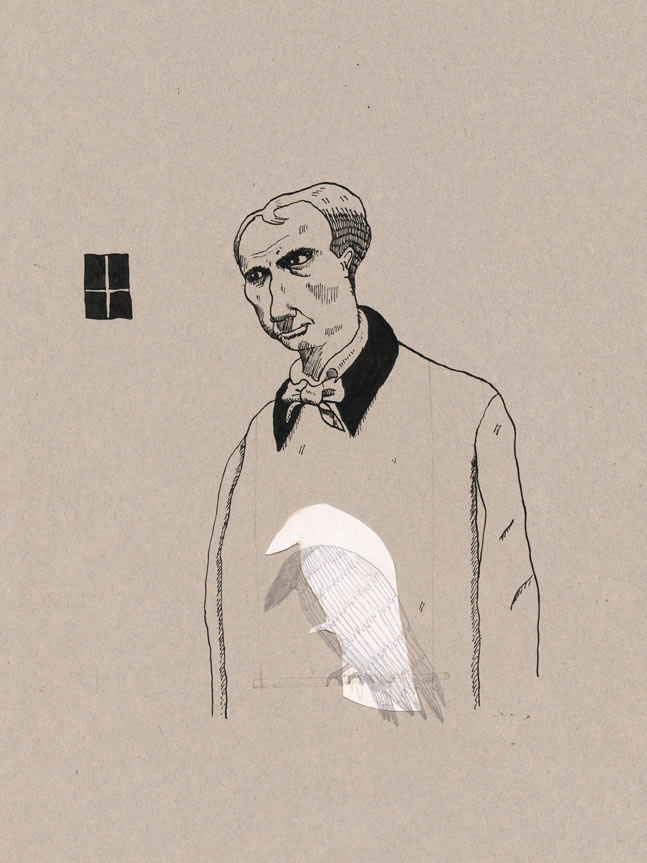

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.