
“Per nulla al mondo – Pour rien au monde”, uscito nel 2010 per l’Orecchio di Van Gogh, torna in libreria in una nuova edizione per La scuola di Pitagora, a cura di Massimo Carloni, con il complemento di alcune lettere di Simone Boué indirizzate all’autrice Friedgard Thoma.
Père Lachaise, il cimitero di Parigi, uno sguardo assorto in direzione di una donna in stato di gravidanza e il principio di un mondo è lì a compiersi nel titolo dell’opera L’Inconveniente di essere nati. Un pensiero che zigzagando tra poesia e aforisma, si inerpica sul lubrico sentiero alla ricerca di un senso. Indagine che l’autore del libro, Emil M. Cioran, sviluppa in dodici capitoli di amara e folgorante consapevolezza. Otto anni dividono la nascita dell’opera (1973) dalla presa di una giovane professoressa tedesca (1981), Friedgard Thoma: comme on dit, galeotto fu L’Inconveniente di essere nati.
Numerose le lune disincantate trascorse sopra la vita del filosofo rumeno, una mole che dispone l’uomo nella collocazione strategica per essere trafitto da una detonazione chirurgica. Un congegno preciso sino all’incredulità, una sorta di cecchino caricato a passione che giunge nel momento giusto, colpendo l’autore sino all’ultima parola. Un cuore prostrato e con la guardia abbassata da tempo, descrive il miglior bersail per accomodarsi ai piedi di un ardore vivo e martellante: una donna inaspettata. L’eros penetra in Cioran alla maniera di una malattia. Malessere che si incunea brutalmente senza trovare resistenza alcuna. La sola opposizione è negli scritti di un “fu cinico”: ma pessimismo e nichilismo non delineano sovente l’esito di un “prima”, danneggiato nel ventre di un’idea, di un idealismo finanche storico o di un intimo debilitato?
Cara Friedgard,
ho pensato a Lei e a tutto quello che sarebbe potuto essere giovedì sera… se non avesse opposto resistenza. L’ho sentita sospirare e piangere. Per oltre un’ora le scene più intime si sono svolte nella mia mente, con una precisione tale che mi sono dovuto alzare dal letto per non impazzire. Abbiamo discusso troppo. Ho compreso in maniera chiara di sentirmi legato sensualmente a Lei solo dopo averle confessato al telefono che avrei voluto sprofondare per sempre la mia testa sotto la sua gonna. Come possono essere letali certe cose. – Tutto in fondo è cominciato dalla foto, con i suoi occhi direi.
Friedgard Thoma entra nella vita dello scrittore con la grazia di una lettera, il magnete di una foto e la potenza di un giovane uragano. Tempesta che trascina via ogni precedente convinzione sull’amore e fa di Cioran un uomo. Una creatura che abbandona il vecchio pudore di mostrarsi in tutta la fragilità di un debilitato dal sentimento. L’avvincente professoressa, donna nella completezza di una miscela letale di intelletto ed eros, muove i fili di una relazione che non vedrà mai il tramonto definitivo. La passione di Cioran è travolgente, una fiumana che lo trae in un pensiero fisso: un’ossessione di mente e carne. Dove è finito il Cioran pessimista, nichilista, cinico che non sente alcuna attrazione carnale per le donne con le quali stabilisce solo un’empatia intellettuale? Un vortice di ripensamenti sull’intera opera o una nuova prospettiva da adoperare?
Come può capitare, ad uno scettico di professione come me, di assumere un’attitudine così anti-scettica?
Accade poiché l’unica salvezza dell’essere umano è proprio nel ventre di quel sentimento fortemente maltrattato, fonte di impaccio e trattenuto nella sprovveduta convinzione di immortalità. È l’amore, quella giostra incredibile che in un istante porta in vetta, e in quello successivo, cala negli abissi più oscuri. E se lo si considera solo alla stregua di una bagattella, forse, di fatto, non lo si è mai incontrato. Tale riflessione perviene proprio da Al culmine della disperazione; alla luce dei fatti, degli ultimi anni e della Thoma, si potrebbe dunque ipotizzare uno strano caso di nichilismo profetico? Negare e negarsi qualcosa nella scrittura come atto per riaffermarsi con ancora più veemenza nella vita.
Gli inizi della loro relazione grondano di impeti e parole, di lettere e telefonate; pulsioni che portano a un rendez-vous anche fisico e a vivere una prima frattura. I due sono divisi da molti anni, Friedgard è giovane, il filosofo è già transitato sotto l’impietoso rigore del tempo. Per la donna le due diverse carnalità delineano un limite, guastando l’illusione di un amore puramente cerebrale. Per Cioran l’erotismo interrotto è la stillante ferita che solo il tempo farà meno dolorosa. Friedgard è il richiamo dell’intelletto capace di parlare di Nietzsche, di poesia e di riportarlo finalmente alla musica.
Cara Friedgard,
devo a Lei il mio ritorno alla musica – e questo non lo dimenticherò mai più.
In tale prospettiva la Thoma figura un azzardo: la donna completa. Cioran dispone di tale consapevolezza, ma non della forza di abdicare. I fili della donna si spostano sopra il verso di un’intima amicizia, fatta di confronti e passeggiate sino a un’importante conquista: la fiducia della compagna di sempre dello scrittore, Simone Boué. Da un attacco fatto di lettere e telefonate ardenti, il tempo si farà medicamento, i toni volgeranno alla pacatezza e alla profondità di un amore importante. Il carteggio fissa la liturgia di un sentimento senile, nella perturbante dicotomia tra eros e rituali di inabissamento. Oltremodo una guida per il filosofo nella rivisitazione della misoginia delle sue prime opere. Un Cioran impensato, tratteggia la sentinella nell’opera di Friedgard Thoma.
Di seguito la lettera cuore del carteggio:
Cara Friedgard,
Ho appena riletto la Sua lettera pervasa di poesia – ho pianto (piango spesso da quando la conosco!). Ieri ho letto una citazione dalla Maitri Upanisad: il nostro corpo sarebbe una massa di lacrime. Quattro mesi fa, prima del suo viaggio qui, non avrei potuto sostenere questa affermazione in base ad una mia esperienza personale. Folle, bellissimo, straordinario! Da sempre ho tentato di liberarmi dalla ‘creatura’. La solitudine era la mia religione. In verità mi sono sempre sentito solo – con delle eccezioni tuttavia: la più singolare è la presente. Lei è diventata il centro della mia vita, la dea di uno che non crede in nulla, la più grande felicità e sventura che mi sia capitata. Order? Se pronunciasse questa parolina, ed io fossi morto, risorgerei all’istante. Dopo che per lunghi anni ho parlato con sarcasmo di tali… cose come l’amore (e simili) dovrei essere punito in qualche modo, e lo sono, ma non importa. Il fallimento è il punto cardinale del mio programma. Tuttavia ho una qualche possibilità: Lei è propensa a vivere ai margini, anche se solo un poco, ma questa riserva è già tanto – almeno per me. Mi considero un marginale, e interiormente reagirei come tale anche se venissi tradotto in tutte le lingue del mondo, compresa quella dei cannibali. Gli ultimi due versi di Eichendorff e gli altri ‘una Stella’ erano del tutto consoni al mio 14 luglio emotivo. Lei ed io, condividiamo certamente un ‘lato notturno’ e se penso a questa ricchezza comune, come pretendere che queste maledette lacrime non si impadroniscano ancora di me?
Sarà per quel nulla al mondo, ma sembra che siamo fatti di quel nichilismo che auspica l’amore.
* Friedgard Thoma, Per nulla al mondo – Un amore di Cioran. La scuola di Pitagora edizioni, a cura di Massimo Carloni, traduzione di Piepaolo Trillini, revisione di Massimo Carloni e Lilla Mentrasti.
- da Barbadillo, 4 febbraio 2017







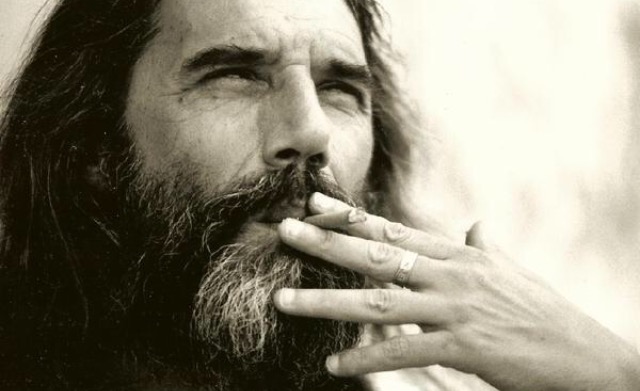

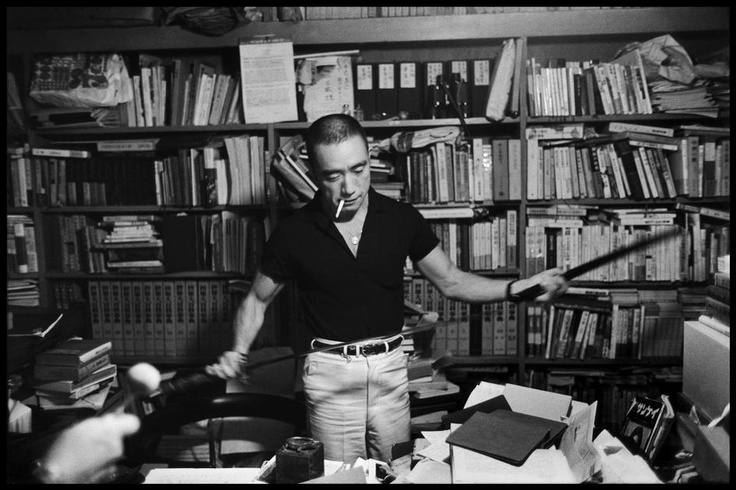
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.