
Accade che una vasta sorgente di verde accolga il fiore della poesia nel busto di Charles Baudelaire. Succede che quel rigoglio di sentieri dilati la sua vegetazione per porre l’ascolto alla musica suggerita dal busto di Beethoven. Capita che quello stesso giardino di trentacinque ettari si distenda per ospitare il generoso incedere di un piccolo uomo con indosso due cappotti e delle grandi scarpe teatrali. E accade che quell’uomo sia Paul Léautaud, lo scrittore che consuma la sua vita tra i castagneti parigini del Luxembourg e la sua giungla personale di Fontanay-aux-Roses.
Dopo il lavoro al Mercure e prima del rientro a Fontanay, Paul Léautaud sospende il tempo presso il jardin per salvare un gatto dal freddo, un cane dalla fame, un animale da un uomo. E allora questo ami et protecteur des chats et des animaux, giunge tra i passaggi fioriti per vedere germogliare ancora una volta la vita.
Paul Léautaud è lo scrittore che frequenta la scuola della purezza. E cosa significa essere uno scrittore puro? Vuol dire ignorare la compiacenza, disinteressarsi della critica, scrivere senza pensare alla pubblicazione.
Scrivo solo per me, non ho la minima certezza di essere letto un giorno. Probabilmente non sarò più vivo. Quindi sono assolutamente sincero.
Non esiste alcuna dilazione tra lo scrittore e l’uomo: qui l’uomo è la scrittura e la scrittura è l’uomo. L’essere libero, franco fino alla spietatezza, onesto nello sguardo che si fa inchiostro e poi parola. Léautaud è un realistico corrispondente della vita: registra la realtà che si consuma davanti al suo sguardo per poi riferirla alla chiamata della pagina. L’autore non indugia sulla alterazione dei fatti, non è interessato all’esito, dunque non scrive per fare colpo sul lettore. La libertà è un valore che riporta nella scrittura, l’onestà è il solco che segue e persegue la sua penna. Una letteratura onesta che giunge diretta sino a farsi brusca perché la franchezza frequenta gli spigoli, le punte aguzze, gli aculei. L’autenticità è scomoda ma Paul non può fare a meno di incalzarla realizzando la grande fusione tra la scrittura e l’uomo.
Bisogna scrivere ciò che si è visto, ciò che si è inteso, ciò che si è provato, ciò che si è vissuto.
Con la sua andatura curiosa, Paul lambisce le strade parigine: il flâneur si perde nel grembo della città, l’unico ventre caldo capace di accoglierlo. Perché se Parigi è l’eterna presenza, la figura materna è l’eterna assenza. Paul nasce nel 1872 al 37 di rue Molière nel I arrondissement di Parigi, dall’unione tra Firmin Léautaud e Jeanne Forestier. Il 1872 è un anno bisestile: a Giverny in Normandia Claude-Oscar Monet realizza Impression, soleil levant; in Italia il Vesuvio vive un’importante eruzione; negli Stati Uniti apre il Parco Nazionale di Yellowstone e Parigi vede la nascita di uno dei più importanti autori del Novecento francese: Paul Léautaud.
Firmin Léautaud, impenitente seduttore, lavora come suggeritore presso la Comédie-Française. Jeanne Forestier è un’attrice teatrale. Paul cresce tra l’indifferenza paterna e le cure di maman Pezè, la domestica del padre. Abbandonato a cinque giorni dalla nascita, il piccolo Léautaud non conosce l’amore materno. Nel corso della sua vita incontra la madre solo quattro volte. Il ruolo che riveste la figura di Jeanne Forestier è quello della grande assente. Assenza che orienta tutta l’esistenza di Lèautaud, tanto da condurlo a una vita sentimentale recisa e manchevole, come se una sorta di epitaffio sul cuore recitasse che si ama come si è stati amati. Lo scrittore costruisce relazioni soprattutto con donne più grandi, sovente dedite alla prostituzione e mai particolarmente belle. Legami edificati sul rapporto carnale, dove il sesso rappresenta l’unico modo di amare: la carnalità si sostituisce al cuore, non c’è spazio per afflati trascendentali fuori dal corpo. L’unico turbamento che coinvolge lo scrittore è quello che sente per gli animali, stimati come dei veri amici.
E proprio in materia di diritti degli animali, Léautaud può essere considerato, non a torto, un importante precursore: già nel 1937 si schiera apertamente contro la vivisezione, battendosi in seguito contro la corrida e soprattutto contro la caccia. Finanche i villeggianti non passano indenni sotto la scure delle sue invettive, considerati esseri frivoli poiché colpevoli di sacrificare le bestie al capriccio della villeggiatura. Spende parole al vetriolo anche contro lo sfruttamento degli animali nel circo. Nel corso degli anni la sua casa di Fontenay-aux-Roses offre alloggio a più di trecento gatti, almeno centocinquanta cani, un’oca e Guenette, la scimmia salvata da un circo. Il narratore parigino dispone il suo mondo dalla parte degli animali, anteponendo i loro bisogni ai suoi. In tal modo stabilisce una grande distanza tra sé e gli uomini. La sua capacità di amare abbraccia appieno solo l’universo animale, tanto da considerare cani e gatti come delle personcine. Se proprio deve confrontarsi con degli esseri umani, predilige frequentazioni moralmente riprovevoli.
Spesso un furfante è un uomo superiore, a disagio in mezzo ai nostri pregiudizi.
Le grandi assenze si consegnano all’epidermide, narrano un profumo, reclamano un sapore, necessitano della costruzione di un ricordo che non esiste. Le grandi assenze vivono la forza che diserta la presenza, descrivono delle presenze archetipiche che custodiscono l’autorità di un lutto e il potere di una nascita. Le grandi assenze sono bellezze dolorose inguainate da tendaggi scuri, vale a dire oscuri.
Presenze dal sapore acre prosperano sino a diventare delle ossessioni. Accade con gli affetti mancati come con quelli perduti. Abbandonato dalla madre a pochi giorni dalla nascita, Léautaud matura per questa tenerezza mancata una vera e propria fissazione. Come scrittore autobiografico, porterà la figura materna in molti dei suoi scritti: da Petit ami a Lettre à ma mére. Nonostante l’abbandono, Jeanne Forestier svolge un ruolo importante tra Paul e la scrittura: è lei stessa a muoverlo al romanzo.
Se fossi in te, scriverei un romanzo sulla tua vita. È un tema fecondo, e a svolgerlo bene potresti fare la tua fortuna solo con quello. Non ci hai mai pensato?
Léautaud vive ogni istante tra l’urgenza della scrittura e il bisogno di ravvivare quel passato privo di amore per farne infine letteratura.




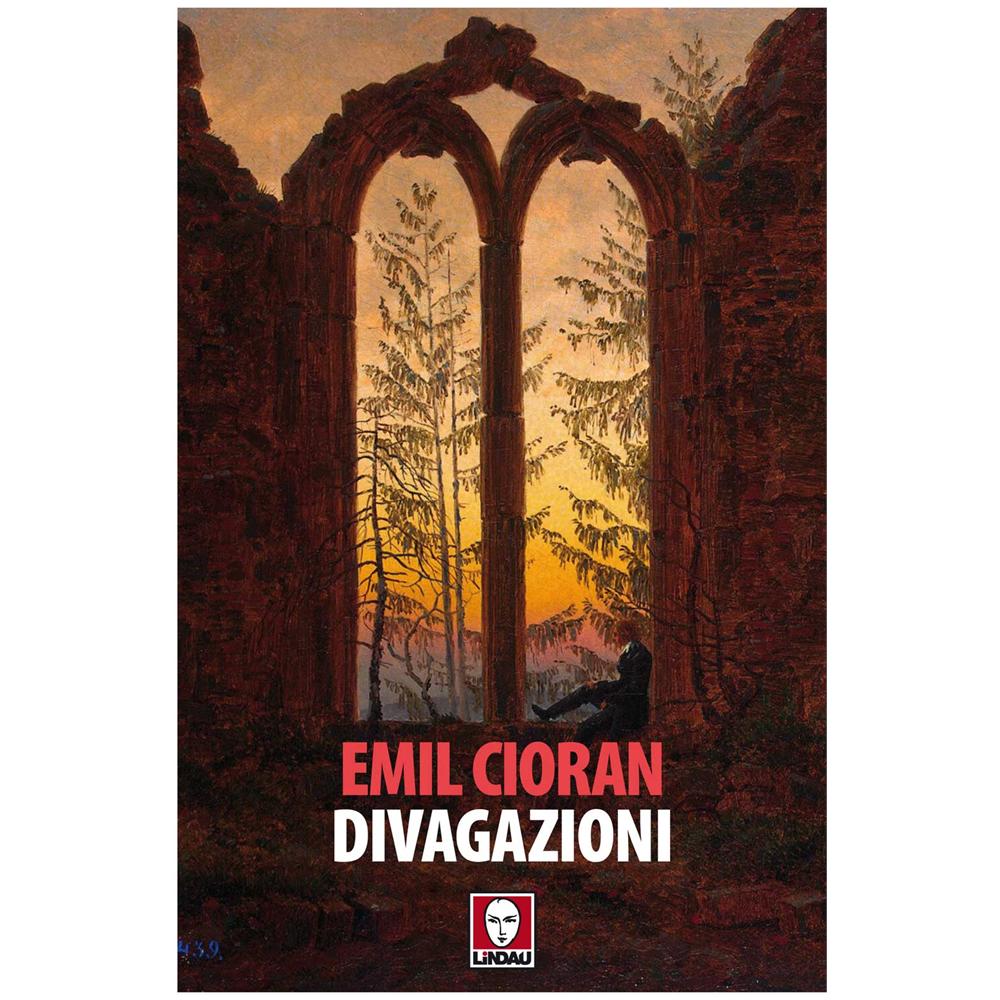


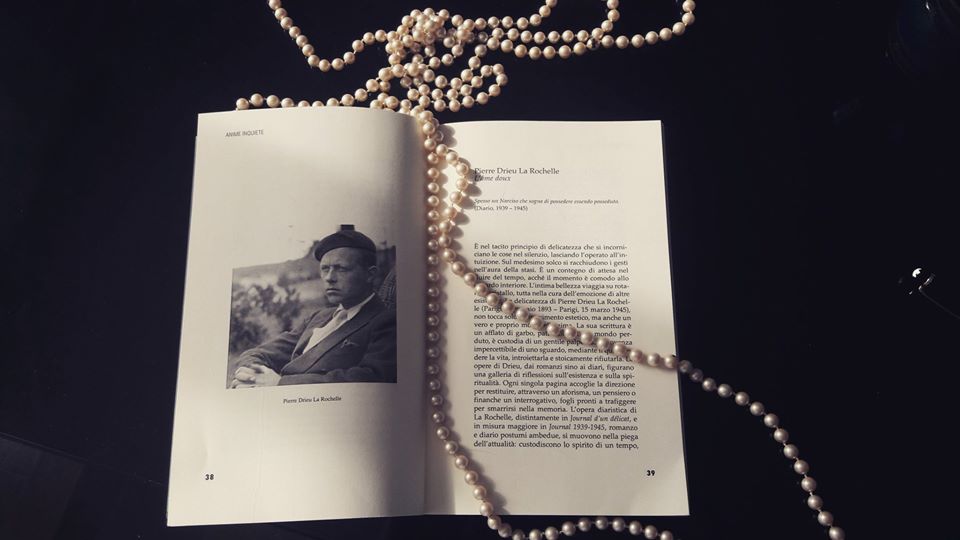


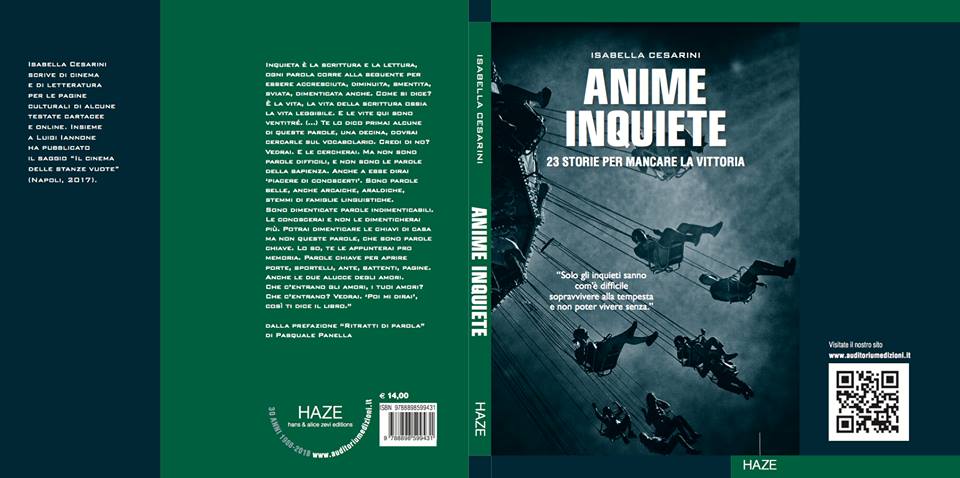
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.