
- Da figura mitologica, la musa prende a vivere dentro l’opera pittorica, nel romanzo e nella poesia come imperativo sine qua non: virtù, prodigio o necessità indissolubilmente legata all’artista. È la presa invisibile che brandisce il pennello del pittore, l’inchiostro impercettibile che sospinge la penna dello scrittore. La spinta lavica dove il maschio artistico si fa madre, amante, amica in un imbracciare la femminilità che solo una dea ispiratrice può generare.
È il profumo dell’Heliconia a farsi sentinella di ogni opera d’arte. Il nome del fiore giunge direttamente dal monte Eliconia, luogo reso illustre dalla mitologia greca sulle muse. Nove figure, figlie di Zeus e Mnemosine, denominate Eliconie nella Teogonia di Esiodo. Anticamente avvolte nell’arte della musica, guadagnano imponenza nel tempo come custodi di ciascun fiotto di pensiero. Attraversano lo spazio/tempo in un divenire perpetuo che, da seducenti scrigni di arte, si fanno lucenti volte d’ispirazione per numerosi artisti. Non vuote sagomature da ritrarre, ma femmine di Zefiro che nel soffio fecondano nel maschio non una, ma molteplici Flora botticelliane. La musa, da mito prende vita nell’opera pittorica, nel romanzo e nella poesia come imperativo sine qua non: virtù, prodigio o necessità indissolubilmente legata all’artista. È la presa invisibile che brandisce il pennello del pittore, l’inchiostro impercettibile che sospinge la penna dello scrittore. La spinta lavica dove il maschio artistico si fa madre, amante, amica in un imbracciare la femminilità che solo una dea ispiratrice può generare.
Calliope, Clio, Urania e le restanti muse riemergono nel ‘900 nelle monumentali figure di Jeanne Hèbuterne, Elena Ivanovna Diakonova (Gala) e Marta Marzotto. Jeanne Hèbuterne figura i molteplici volti della disgraziata vita del pittore Amedeo Modigliani. Con l’appellativo “noix de coco” per i lunghi capelli e un volto che tratteggia la perfezione, Jeanne rappresenta la creatura che s’immola per l’arte nella vita e dentro la morte in una missione artistica tutta di Modì. Modì che è altresì maudit e ancora l’incontro con la musa Jeanne rappresenta l’esuberanza amorosa in assenza di argini. Noix de coco è l’empito creativo, la madre, l’amante e colei che nella fine dell’amato trova l’unica via di sopravvivenza nel darsi la morte. Amedeo Modigliani muore il 24 gennaio 1920 di meningite tubercolotica. Jeanne Hèbuterne , al nono mese di gravidanza, abbandona l’esistenza privata di Modì, lanciandosi da una finestra. Un volo che è feroce distacco e struggente ricongiungimento in quell’altrove che solo l’artista insanamente intende. Il pittore e la musa, la morte e la vita, l’eccesso e la quiete ricongiunti in un’infinita e infausta opera d’arte. Per volere dei familiari della Hébuterne, del tutto maldisposti alla relazione vissuta con Modigliani, la dea dei suoi dipinti viene tumulata nel museo parigino di Bagneaux. Solo nel 1930, i resti vengono posti accanto al suo “Dedo” nel cimitero di Père Lachaise. La commovente passione di Jeanne per Modì è tutta dentro la solennità di un epitaffio:
Devota compagna sino all’estremo sacrificio
E se il profumo dell’Heliconia agita la Parigi dei primi del ‘900, il suo elisir cosparge l’esistenza della musa delle muse: Gala Éluard Dalí. Divina del pittore dei pittori, Salvador Dalí, Gala è dapprima refolo illuminante per il poeta Paul Éluard e in seguito si fa fulgida musa per il re del surrealismo. Salvador Dalí, tutto genio, follia e fragilità si raccoglie in una resa: l’evidenza di un amore assoluto. Assolutismo passionale che si farà antidoto magico di ogni male:
Poteva essere la mia Gradiva (colei che avanza), la mia vittoria, la mia donna. Ma perché questo fosse possibile, bisognava che mi guarisse. E lei mi guarì, grazie alla potenza indomabile e insondabile del suo amore: la profondità di pensiero e la destrezza pratica di questo amore surclassarono i più ambiziosi metodi psicanalitici.
Gala è la musa, la solidità, lo slancio e l’apertura che si faranno meraviglioso balzo in tutto il surrealismo nella grandiosa opera di Dalí. La devozione del pittore spagnolo è tale da rappresentare una forma di insaziabile dipendenza affettiva. Alla morte di Gala, avvenuta nel 1982, l’afflato ispirato dell’artista, la seguirà nella sua fine, dissolvendosi in lei e con lei. Ancora l’effluvio di Heliconia si allunga nell’aura di un’altra figura mitologica da poco scomparsa: Marta Marzotto. L’appuntamento incandescente con il pittore siciliano Renato Guttuso, accade inevitabilmente in una giornata di canicola romana; estate che nel clima e nei colori si farà metafora della loro passione. Lei modella sinuosa, da Vacondio si fa contessa Marzotto per rinascere in una Talia, musa del Thallein, del fiore. E come bocciolo si schiude e scorre nell’opera dell’artista impegnato: il comunista e la contessa. Un amore rovente e contrastato, epifania del batticuore carnale fuori da qualsiasi avveduta sbozzatura.
All’interno di un’affermazione particolarmente abusata, attribuita a Virginia Woolf e riferita al detto latino Dotata animi mulier virum regit (una donna dotata di coraggio sostiene il marito), ossia Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, si azzarda una rivisitazione del caso: Dietro un grande artista, c’è sempre una grande musa. Ispirazione fatta forma femminile, la figura mitologica della musa sfugge la fissità della leggenda per farsi vita pulsante nella creazione artistica. Jeanne, Gala e Marta non figurano come l’oggetto passivo dell’esecuzione artistica quanto soggetto attivo del festeggiamento creativo. La dea ispiratrice, nell’avviarsi a quel percorso infinito, costeggia generi ed epoche diverse. Indugia nella letteratura, si fissa in un ascolto musicale per accomodarsi nel buio di un cinematografo. Elizabeth Craig per Louis-Ferdinand Céline, Pamela Courson per Jim Morrison o ancora Charlotte Gainsbourg per Lars von Trier, sono solo il primo passetto verso la volta infinita occupata dal profumo dell’Heliconia. Ma questo è un altro capitolo, bellissimo e inesauribile.
Alle muse!
- da L’Intellettuale Dissidente, 14 settembre 2016




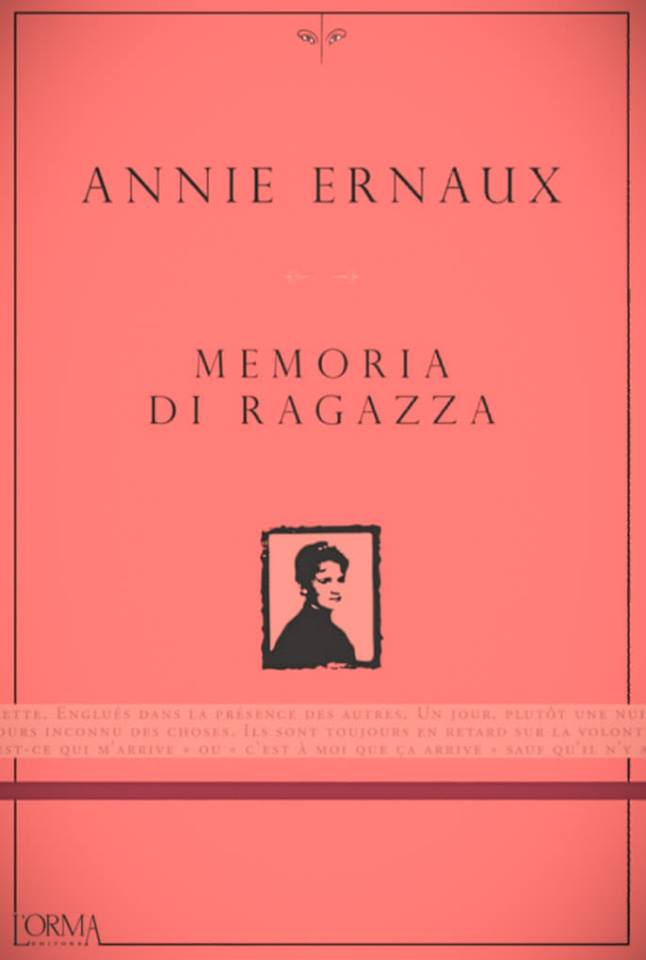





Devi effettuare l'accesso per postare un commento.